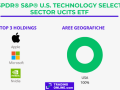Il limite è quello posto alla logica economica che spinge alla totale privatizzazione della Terra e all’imperativo del profitto a tutti i costi.
Secondo alcuni, nel nostro paese, la riflessione e l’azione politica relativa ai beni comuni si è fatta evidente soprattutto con il referendum popolare del 2011, quello intitolato “Due sì per l’acqua bene comune”. Per altri, nel 2015, con la pubblicazione dell’Enciclica “Laudato si’” di Papa Francesco, siamo entrati nell’era dei beni comuni planetari e dell’ecologia integrale. Se con la Terra e l’ambiente non impareremo ad usare i beni senza mangiarceli, noi distruggeremo tutto.
Non è questione di “benicomunismo” e neanche di ecologismo Nimby (Not in My back yard, non nel mio cortile). Di fronte all’ecocidio, protagonisti, complici, vittime e testimoni muti, tutti, tutti siamo ambientalisti e, se non lo siamo, dobbiamo diventarlo, perché tutti abbiamo un problema di impronta ecologica (vale a dire il consumo di risorse naturali rispetto alla capacità dei cicli vitali di rigenerarle). Le cose cambiano o, meglio, degenerano in fretta, e la crisi ecologica è tale che anche le categorie politiche devono essere ripensate. Per qualcuno “il Green New Deal è il socialismo del nostro secolo, completamente diverso da quello dei due secoli precedenti”, per altri si tratta di ripensare la democrazia rappresentativa, trovando un posto nella legislazione per questa nuova categoria giuridica. Per tutti si tratta di una conversione ecologica, si tratta diventare custodi della casa comune, custodi della sua bellezza e della sua bontà. Si tratta di beni attorno ai quali creare una comunità di cura collettiva, rafforzando il senso di cittadinanza attiva. Non si tratta di destra e di sinistra, che pure esistono e non sono quelle di ieri, non si tratta neanche di creare un nuovo partito o una nuova politica, di cui pure ci sarebbe assoluto bisogno, ma di dare vita ad un pensiero e ad un’azione, ad un movimento metapolitico, transculturale e interdisciplinare.